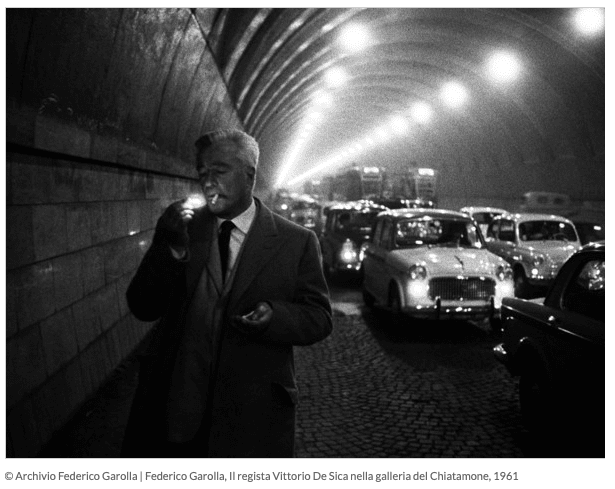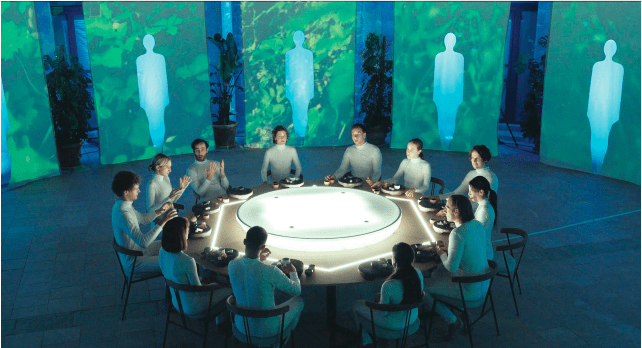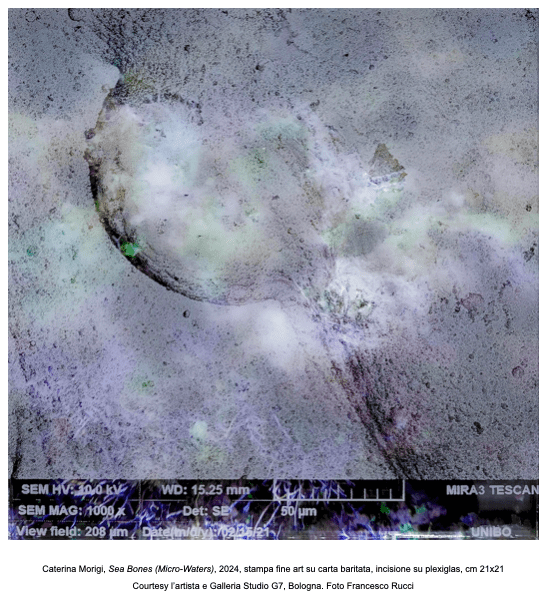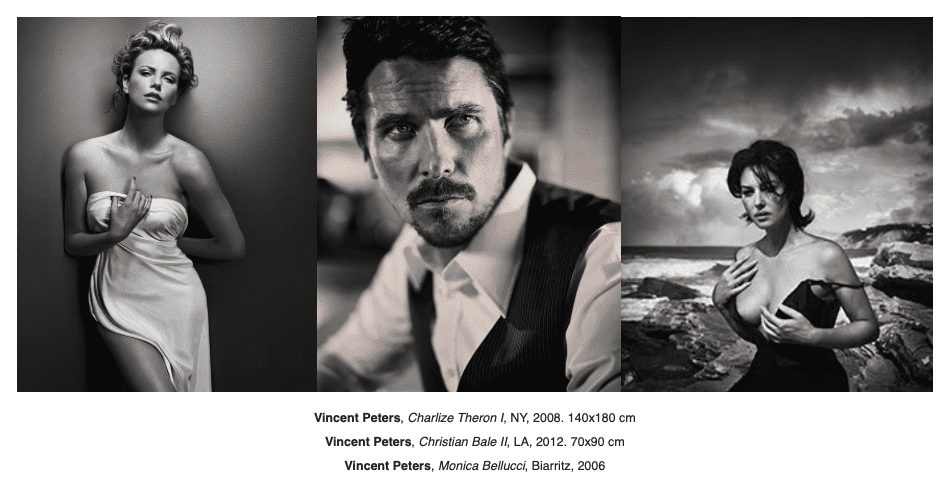CAPITOLO IV
Focalizzazione e forme discorsive
1. Focalizzazione e punti di vista: problemi teorici.
Il problema della focalizzazione nel cinema ha provocato un dibattito teorico ancora oggi in gran parte aperto. La questione più controversa verte su una definizione comprensiva ed esaustiva di focalizzazione e sulla difficoltà che presenta il discorso filmico di rintracciare al suo interno le marche dell’ enunciazione. Genette ha introdotto per primo il termine focalizzazione per designare il rapporto tra il sapere del narratore e il sapere del personaggio. E’ diventata ormai classica la sua distinzione tra il racconto “non focalizzato”, o a “focalizzazione zero”, “rappresentato in genere dal racconto classico”, in cui il narratore sa e dice più di qualunque personaggio, il racconto a “focalizzazione interna”, in cui il narratore dice solo quello che sa il personaggio, e a “focalizzazione esterna”, caso del racconto “oggettivo”, in cui “il protagonista agisce davanti a noi senza che siamo mai ammessi a conoscere i suoi pensieri o i suoi sentimenti” . Genette aggiunge subito che non è sempre possibile definire con certezza il modello di focalizzazione adottato e che il passaggio da un modulo all’ altro è di gran lunga più frequente di un’ opera intera che mantenga sempre lo stesso punto di vista . La distinzione di Genette ha trovato alcune difficoltà teoriche ad essere applicata al cinema, in quanto questo mezzo coinvolge anche il vedere dello spettatore: la divisione tra “chi parla?” e “chi vede?” riguarda, nel cinema, due realtà ben distinte: “il sapere del narratore in rapporto ai suoi personaggi” e “la sua localizzazione in rapporto agli avvenimenti che racconta” . Jost, dopo aver notato che il cinema può nello stesso tempo “mostrare ciò che vede il personaggio e dire ciò che egli pensa” , propone di distinguere tra focalizzazione, ciò che il personaggio sa, e ocularizzazione, “la relazione tra ciò che la camera mostra e ciò che si presume veda il protagonista” . L’ ocularizzazione, come la focalizzazione, può essere zero (esterna) oppure interna (è il caso della soggettiva) . Il problema di definire la soggettiva è al centro delle riflessioni di André Gardies: questi propone di distinguere tra oggetto focalizzato e oggetto focalizzatore (la camera) : quando il focalizzatore si trova collocato in prossimità del personaggio che guarda (il focalizzato), adottandone lo stesso asse di visione, si avrà focalizzazione interna. Se invece il focalizzatore è collocato al di fuori dello spazio diegetico del focalizzato si è in presenza di una focalizzazione esterna . Tuttavia lo stesso Gardies riconosce che per la focalizzazione zero il problema non trova una soluzione: “appare proprio paradossale lo statuto di questa focalizzazione zero che si definisce come non focalizzazione pur facendo parte del sistema delle focalizzazioni” . La focalizzazione filmica rimane comunque, “in quanto istanza narratologica, il risultato di una costruzione effettuata a livelli del sintagma, e non della sola inquadratura” : poiché un film non può raccontare senza mostrare, la focalizzazione appare costitutiva dell’ atto narrativo. Nel racconto scritto vedere e sapere si enunciano nello stesso modo; il racconto filmico invece, nel momento in cui produce i suoi diversi regimi di focalizzazione, costruisce il sapere dello spettatore: è il sapere dello spettatore che definisce la focalizzazione esterna e la focalizzazione interna . Anche Lagny, Ropars e Sorlin, in un testo collettivo, sostengono che nel cinema sia attestabile solo la focalizzazione interna, sia che dipenda da un personaggio (la focalizzazione interna per Genette), sia che mobiliti lo sguardo esclusivo della camera (per Genette focalizzazione esterna, focalizzazione interna-camera per i tre autori) . Essi definiscono la focalizzazione interna come il momento in cui “le facoltà percettive di un personaggio (sguardo o udito) mediano per lo spettatore la possibilità di vedere o sentire” ; quindi chiamano “focalizzatore il personaggio al quale è attribuita la percezione e focalizzato l’ oggetto, quale che sia, che mobilita il suo sguardo e di conseguenza quello dello spettatore” . Nel cinema non è possibile rilevare una focalizzazione interna senza che, prima o poi, venga focalizzato il personaggio focalizzatore . Propongono poi di distinguere tra flusso mentale (monologo interiore) e focalizzazione interna: “il cinema obbliga qui a distinguere ciò che la narratologia tende a confondere, facendo del monologo interiore il tipo più puro du focalizzazione interna” . Il film invece può offrirci un sapere sul flusso mentale del personaggio, ma può non proporci niente sul suo vedere; altra cosa sono le allucinazioni, che appartengono totalmente alla sua attività percettiva . La focalizzazione interna, contrariamente al monologo interiore, non ci offre nulla dei pensieri del personaggio, ma coinvolge solo la sua percezione; “inoltre il cinema conferma sia lo scarto che le zone di coincidenza possibile fra l’ attività immaginante (flusso mentale attribuito ad un personaggio) e la rappresentazione dell’ immaginato (trascrizione indiretta di questo flusso mentale). Nel passaggio da un processo all’ altro, ciò che cambia è lo statuto dell’ istanza enunciatrice” . Le “marche formali di enunciazione” , cioé quei segni particolari che manifestano la presenza di un’ istanza enunciazionale, consistono per Lagny, Ropars e Sorlin, negli “spostamenti particolari della camera o gli effetti specifici di messa in quadro e di montaggio che mobilitano un intervento autonomo del discorso filmico. Attirando così lo sguardo dello spettatore, il film lo invita a cercare una informazione” . Le marche dell’ enunciazione attirano l’ attenzione su un elemento semantico: di fatto “si collocano altrove, fuori del campo della narrazione; quando codificano o manipolano le immagini da vedere, i suoni da sentire, i collegamenti da stabilire, esse programmano le percezioni” dello spettatore. Per punto di vista si intendono quindi concetti differenti: come ha riassunto Jacques Aumont questa espressione può avere quattro significati diversi: la posizione della macchina da presa; l’ immagine presa da una determinata posizione; il punto di vista narrativo (che è dato dal rapporto tra i primi due significati); e, infine, il giudizio del narratore sull’ avvenimento . Questa coincidenza di significati in una sola locuzione nasce, per Aumont, dalla doppia natura dell’ immagine filmica: mostra, cioé “fa vedere qualcosa che non è qui ma si suppone esista da qualche parte” e insieme significa, produce senso mobilitando rappresentazione e iconismo . “Dare a vedere” e “dare a capire” non esistono al di fuori della narrazione . I tre livelli di significazione dell’ immagine filmica (rappresentativo, narrativo e simbolico) sono inscindibili tra di loro . Lo spettatore dunque è guidato dal racconto: questo lo pone in un “luogo (…) capace di stabilire un legame tra finzione ed enunciazione o, più precisamente, di assicurare tra queste due istanze un passaggio” . Secondo Sandro Bernardi la ricerca sui punti di vista raggiunge il suo grado di maggior precisione con Edward Branigan : questi sostiene che nel cinema non sia possibile “individuare punti di vista oggettivi da contrapporre a punti di vista soggettivi, ma solo diversi livelli di soggettività” . Branigan nota come basti connettere due sguardi con due inquadrature successive o con un movimento di macchina per far sì che un’ inquadratura oggettiva diventi una soggettiva dal punto di vista di un altro osservatore. Questo procedimento è ipoteticamente infinito e tale da mettere in crisi ogni concetto di oggettività al cinema : tutte le inquadrature sono potenziali soggettive. L’ ultimo livello di soggettività corrisponde al punto di vista del narratore : tuttavia questo termine è ingannevole, rappresenta un antropomorfismo, in quanto l’ unica realtà attestabile è la narrazione, “una costruzione che non può manifestare il suo costituirsi, il suo momento generativo, e che per questo avrà sempre un carattere impersonale” . Non si tratta di un soggetto inesistente, ma piuttosto di un soggetto in fuga, “stratificato, impersonale, multiplo, policentrico, anzi, presumibilmente un soggetto senza centro” . Ogni soggetto è prodotto dalla macchina del testo: “alla base di tutto sta il testo come macchina. (…) Così le nozioni di soggetto, di narratore, di narratario, come già notoriamente quella di autore o autore implicito, sono figure prodotte dal testo stesso, e raccolte dal lettore, che attribuisce loro una realtà indipendente ed autonoma, che esse non possiedono” . La polemica sui punti di vista è ben lontana dall’ essere conclusa (ed in questa sede abbiamo brevemente citato solo i contributi maggiori): inoltre al problema del “parlare” e del “vedere” andrebbe ancora aggiunto quello del “sentire” . In ogni caso la posizione più “equilibrata” ci sembra quella di Lorenzo Cuccu, per il quale “la focalizzazione non oppone il vedere al sapere, (…) ma segna precisamente i momenti nei quali il sapere/parlare del narratore si trasmette al lettore in un modo specifico” . Infatti lo stesso Genette ha precisato come per focalizzazione si debba intendere “una restrizione di ‘campo’, (…) una selezione dell’ informazione narrativa rispetto alla cosidetta omniscienza della tradizione” , cioé rispetto all’ informazione completa che rende il lettore omnisciente . “Lo strumento di questa (eventuale) selezione è un focolaio situato, cioé una specie di strozzatura d’ informazione, che lascia filtrare solo quel tanto autorizzato dalla situazione. (…) In focalizzazione interna il punto focale coincide con un personaggio, che diventa così il ‘soggetto’ fittizio di tutte le percezioni, comprese quelle che lo riguardano personalmente come oggetto” . In focalizzazione esterna il punto si trova nell’ universo diegetico ma al di fuori di qualsiasi personaggio. Infine la focalizzazione zero, “il famoso punto di vista di Dio o di Sirio, a proposito del quale ci si chiede periodicamente se esso sia davvero un punto di vista” , diventa, nel cinema, “focalizzazione variabile e, a volte, zero” . Il regista è, a differenza del romanziere, legato ad un mezzo, la cinecamera, che è obbligato a posizionare da qualche parte: “la scelta, in questo come in altri casi, è puramente operativa” . La focalizzazione dunque, in quanto selezione di un’ informazione che può attuarsi attraverso un focolaio percettivo, diventa una notazione fondamentale per la comprensione dell’ esordio, e ancor più per l’ esordio del film noir, basato sulla suspense e quindi sullo scarto tra l’ informazione “completa” e l’ informazione effettivamente trasmessa allo spettatore. Nel film noir si possono distinguere quattro forme discorsive dominanti: 1) la voce narrante off e il flashback; 2) la tecnica a camera soggettiva; 3) lo stile documentario; 4) la narrazione classica in terza persona . Vedremo di seguito in che modo ognuna di queste forme stabilisca nell’ esordio un diverso rapporto con il sapere dello spettatore.
2. Voce narrante off e flashback.
Alcuni film, come I gangsters o Il terrore corre sul filo usano più voci narranti diverse, più punti di vista attraverso i quali si ricostruisce, come un puzzle, la storia (focalizzazione interna variabile). In altri casi la voce narrante è una sola, come, ad esempio, in Il postino suona sempre due volte e La signora di Shanghai : qui la narrazione si pone come raccontata da qualcuno (focalizzazione interna), si simula un ingresso nel mondo interiore di un personaggio o del protagonista; la voce narrante ci ricorda che ciò che vediamo e ciò che capiamo sono sempre e solo il punto di vista di qualcuno, derivano da una sola ed invariata prospettiva. Questo modello narrativo è certamente più interessante del primo per la nostra analisi sull’ esordio. Il postino suona sempre due volte si apre con la voce narrante off di Frank Chambers (John Garfield): un cartello con la scritta “man wanted” è accompagnato dalle parole del protagonista “il posto era vicino all’ autostrada, all’ estrema periferia di Los Angeles…” . La narrazione si identifica subito come un puntuale resoconto dei fatti: Frank sta raccontando linearmente e senza anticipazioni la sua storia. Anche La signora di Shanghai si apre con la voce narrante fuori campo di Michael O’ Hara (Orson Welles): “a volte a me capita di fare una sciocchezza dopo l’ altra, e non c’ è nulla che possa fermarmi; il giorno che incontrai quella donna avrei dovuto fuggire subito (…), ma appena l’ ebbi vista perdetti del tutto la ragione. E irrimediabilmente. (…) Vi sono degli uomini che intuiscono il pericolo. Io no.” Michael anticipa fin dall’ aperura il pericolo che sta correndo, ponendo in questo modo un’ attesa: la promessa di rivelare le conseguenze del suo incontro con Elsa. I due film sono simili sotto molti aspetti: nei due protagonisti vi è il desiderio di conquistare una donna; Cora Smith (Lana Turner) e Elsa Bannister (Rita Hayworth) sono entrambe sposate, si serviranno dei loro amanti, li inganneranno, e, alla fine, entrambe moriranno tragicamente. Ma Frank racconta la storia che vediamo al cappellano del carcere, durante gli ultimi istanti della sua vita, mentre aspetta la condanna capitale per l’ omicidio di Cora, e di Nick. Il suo racconto quindi, anche se localizzato retrospettivamente, è indubitabile: nessuno potrebbe mentire in quei momenti. Inoltre in Il postino suona sempre due volte la focalizzazione sul narratore è completa: la narrazione non cambia mai punto di vista. Michael invece racconta episodi ai quali non può avere assistito, come la discussione di Arthur Bannister con Goldie e Jack, o il momento in cui George Grisby spia Elsa con il telescopio, o ancora il colloquio tra Arthur, Elsa e George durante il picnic. In questi casi la narrazione in prima persona lascia il posto ad una narrazione classica, in terza persona. Michael, ricordando la sua storia, la commenta: fin dall’ inizio si definisce uno stupido per aver seguito quella donna. Quando poi la salva dall’ aggressione, aggiunge : “Mi permise di entrare in scena come un eroe, cosa che non sono sicuramente”. E’ come se volesse cercare una ragione in ciò che è accaduto, riordinare i ricordi nella sua mente : nell’ ultima scena, mentre esce dalla casa degli specchi abbandonando Elsa morente, chiude la possibilità, lasciata ancora aperta dalla diegesi, di essere condannato, informando lo spettatore di una lettera scritta da Bannister al procuratore generale che dimostra la sua innocenza. Ma subito dopo aggiunge: “Innocente, che grande parola questa…stupido bisogna dire” . Il soggetto narrante sembra essere “il primo spettatore del proprio dramma” : giudica se stesso ed il mondo che ha narrato. La sua storia diventa una vera e propria metafora dell’ esistenza: acquista, nel tragico finale, il significato di condanna morale verso l’ avidità e l’ inganno, ed esalta la giustizia della legge. In Il postino suona sempre due volte Frank racconta la sua storia senza giudizi o giustificazioni: alla fine si permette una sola riflessione, spiegando così il titolo del film: si sconta sempre il male commesso. Michael racconta per se stesso la sua storia, Frank per il sacerdote del carcere. La differenza si evidenzia nell’ esordio, nel diverso modo che hanno i due protagonisti di essere narratori – soggetto. Il primo crea fin dall’ inizio un’ attesa, anticipando ciò che accadrà; nel secondo la suspense è data più avanti, dal progetto dei due protagonisti di uccidere Nick. In entrambi i casi c’ è comunque uno scarto d’ informazione: lo spettatore e il narratore-Frank vengono, insieme e gradualmente, al corrente di una situazione che Nick ignora, mentre in La signora di Shanghai il narratore si limita a preannunciare allo spettatore una situazione di pericolo, di cui egli era inconsapevole. Nel corso del racconto dovrà fare in modo di “sdoppiarsi”: nel suo ruolo di vittima non può narrare in prima persona ciò che non poteva logicamente sapere nella successione logico-cronologica degli eventi. Michael si trova quindi in seguito costretto ad “assentarsi” per alcuni momenti dalla storia (narrazione in terza persona), permettendo che lo spettatore venga informato di ciò che lui, in quel momento, ignorava, ricostruendo e alimentando così quel meccanismo di supense che, altrimenti, sarebbe andato estinguendosi subito dopo l’ esordio.
3. La tecnica a camera soggettiva.
Tra i noir che utilizzano la soggettiva in questi anni , il più singolare è certamente Una donna nel lago (Robert Montgomery, 1947), interamente girato con questa tecnica. La soggettiva enfatizza il punto di vista, porta all’ esasperazione la focalizzazione interna su un personaggio: cambiando la normale prospettiva dello spettatore lo allinea forzatamente al personaggio focalizzato, rinchiudendolo nel suo campo visivo e percettivo. Un tale effetto, se prolungato, crea dei problemi nell’ attenzione dello spettatore: come ha notato Telotte, questi si ritrova dietro l’ eroe, anziché di fianco a lui , e quindi perde d’ interesse verso la storia. La soggettiva produce un effetto di instabilità, di disturbo, nella diegesi: definendo l’ identità dello spettatore attraverso quella di un personaggio, la narrazione non gli affida un ruolo da seguire attivamente, ma lo circoscrive in uno spazio percettivo obbligato. Per questo motivo Una donna nel lago diventa man mano sempre meno interessante: acquisito l’ espediente tecnico, allo spettatore non resta che seguire il detective nella sua indagine. Il film inizia con l’ auto presentazione di Marlowe: si conforma così a quella regola cinematografica e cognitiva secondo cui non è possibile definire la focalizzazione interna senza che, prima o dopo, venga focalizzato il personaggio focalizzatore . Marlowe si trova seduto alla scrivania del suo ufficio: “Mi chiamo Marlowe, Philip Marlowe. Professione: detective privato”. Durante questo breve “discorso d’ esordio”, Marlowe guarda sempre in camera: ciò è ovviamente giustificato dal fatto che soggettiva e sguardo in camera sono perfettamente complementari . Inoltre il narratore ci introduce nel racconto: il suo sapere è quello dominante. Subito dopo aggiunge: “In questi giorni radio e quotidiani non fanno altro che parlare di un nuovo omicidio. Lo chiamano ‘il caso della donna nel lago’. (…) Ma quello che leggete e sentite è una cosa, mentre la verità è un’ altra. E c’ è solo un solo uomo al mondo che la sa, e sono io. (…) Vedrete le cose come le ho viste io, e insieme a me cercherete gli indizi, e forse risolverete anche il caso. O forse no. Siete sicuri di sì ? Ok, allora provate. Ma vi dò un consiglio: tenete gli occhi aperti, non vi distraete neanche per un attimo, perché succede tutto quando meno ve lo aspettate”. Il detective propone una vera e propria sfida allo spettatore: gli dà la possibilità di vivere la stessa sua esperienza, concedendogli la libertà di poter vedere i fatti proprio come sono accaduti. In questo modo sarà lui stesso a scoprire la verità. La tecnica a camera soggettiva è introdotta dunque come la più obbiettiva (“…quello che leggete e sentite è una cosa, ma la verità è un’ altra…”): dal sapere dominante del narratore, il detective sembra lasciare allo spettatore la libertà di scoprire egli stesso la dimensione reale dei fatti, con pura obbiettività. Ma in effetti accade l’ esatto contrario: non vedremo le cose come le ha viste Marlowe, ma vedremo Marlowe vedere le cose. Con la soggettiva la distanza tra il narratore e lo spettatore si cancella, ma a svantaggio di quest’ ultimo. Chi vede è sempre il detective: lo spettatore è costretto nel suo campo percettivo, non possiede alcuna libertà. Ciò che Marlowe promette sembra, allo spettatore moderno, la pubblicità di un videogioco interattivo: ma questa tecnologia, estremamente sofisticata, simula l’ingresso completo dell’ utente in un mondo virtuale con tutti i suoi sensi, permettendogli di agire come nella realtà. Proprio una simile discrepanza sembra rammicare il recensore del film del “New York Times”, nel 1947: “You do get into the story and see things pretty much the way its protagonist, Philip Marlowe, does, but you don’ t … get a chance to put your arms around Audrey Totter…After all, the movie makers for all their ingenuity, can go just so far in the quest of realism” . La soggettiva è quindi ben lontano da offrire obbiettività e oggettività alla narrazione. La camera, in questa prima parte dell’ esordio, non rimane fissa, ma si avvicina lentamente fino ad inquadrare in primo piano il volto di Marlowe: questo movimento ha la funzione di assimilare sempre più lo spettatore al narratore, introducendo lentamente l’ annullamento della distanza fra i due durante il film. Rimuovendo questa distanza si cancella a priori anche ogni possibile scarto informativo: ciò che vede e ciò che sa lo spettatore è esclusivamente ciò che vede e ciò che sa Marlowe. In questo modo viene a mancare la condizione stessa per creare la suspense: l’ attesa è provocata solamente dalle scelte di Marlowe: lui solo deciderà dove andare (dove portare lo spettatore) e cosa guardare (cosa fargli vedere).
4. Lo stile documentario.
Nel clima culturale e tecnologico che seguì la Seconda Guerra Mondiale, fiorirono i film noir basati su fatti realmente accaduti e girati con mezzi innovativi (basti pensare alla ripresa della rapina nell’ esordio di Il bacio della morte , in cui la camera era stata posta al 38° piano di un grattacielo, con un obbiettivo che schiaccia i personaggi dentro lo senario metropolitano, procedimento che diventerà abituale nel genere; oppure alle riprese dall’ elicottero nell’ apertura di La donna del bandito ). Questi film sono prodotti quasi tutti tra il 1945 e il 1950 :Boomerang (Elia Kazan, 1947), Chiamate Nord 777 (Henry Hathaway, 1948), Città nuda (Jules Dassin, 1948), Giungla d’ asfalto (John Huston, 1950) e i già citati La donna del bandito (Nicholas Ray, 1949) e Il bacio della morte (Henry Hathaway, 1947). Il noir “documentario” è basato, lo abbiamo detto, su fatti realmente accaduti: usa attori non professionisti, le riprese sono effettuate nei luoghi in cui si è svolta la vicenda, e, in genere, una voce narrante fuori campo attesta la veridicità della storia. Ma l’ attenzione per gli aspetti realistici della vicenda si scontra con i propositi, per una volta apertamente dichiarati, di cui la voce narrante fuori campo si fa portavoce: presentare, più che un racconto avvincente ed interessante, il fascino di una storia vera; rivelare allo spettatore un nuovo modo di vedere la realta, una nuova prospettiva di giudizio . Mentre si offre uno sguardo limpido e obbiettivo sul mondo della criminalità dei sobborghi urbani, si ammette apertamente che la storia, a parte gli aspetti accennati sopra, è finzione. Infatti la spiegazione e l’ introduzione dei fatti è delegata ad una voce narrante off distante ed omniscente, il “punto di vista di Dio” , che commenta e collega tra loro le varie sequenze come in un flashback. Così il narrato si auto-investe dell’ autorità della voce fuori campo, nascondendo la finzione filmica dietro ad una fedele registrazione dei fatti. Questo compromesso si fonda nell’ esordio, nel momento in cui la voce narrante off si propone come garante, perché omniscente, di ciò che sta per raccontare. Il paradosso è particolarmente evidente in La città nuda : il film si apre con alcune vedute della città di New York ripresa da un aereo; la voce fuori campo: “Signore e signori, il film che state per vedere è intitolato ‘La città nuda’. Io mi chiamo Mark Hellinger, e ne ho diretto la produzione. Consentitemi di dirvi che lo ritengo alquanto diverso dagli altri film. (…) Esso non è stato girato in un teatro di posa, al contrario ….” Il film si propone come prodotto: la voce fuori campo si presenta addirittura proprio come il produttore del film che sta per incominciare. Tutto denuncia la costruzione della finzione cinematografica, palesandola quasi sfacciatamente allo spettatore (il produttore nomina tutti coloro che l’ hanno costruita materialmente: il regista, lo sceneggiatore e il fotografo, nonché gli attori). Ma, nello stesso tempo, dichiara di voler raccontare una tra le tante storie di New York, e di volerla narrare riadattandola nei luoghi in cui è accaduta, tra le strade e i grattacieli, non in un teatro di posa. Ecco il paradosso: si palesa la finzione filmica per introdurre una storia vera (che assume così la caratteristica di un flashback). Senza contare che non vi è nulla di meno reale che una voce narrante fuori campo. Eppure questo procedimento accomuna gran parte dei film citati sopra, e si sviluppa sempre secondo le stesse regole: la voce off introduce la città in cui si svolge l’ azione, il più delle volte non è neppure nominata, ma diventa una città qualsiasi, con gente qualunque, la stessa che possiamo incontrare uscendo di casa al mattino. Ciò che accade ad uno “qualunque” potrebbe accadere a noi stessi, un bel giorno. La storia che segue è una di queste. La realtà diventa dunque l’ oggetto del film, e il realismo il meccanismo necessario per la finzione. E’ proprio denunciando la finzione filmica nell’ esordio che il noir “documentario” ottiene questo risultato.
5. La narrazione in terza persona.
La grande maggioranza dei film noir segue questa forma discorsiva: la focalizzazione esterna e, ancor più la focalizzazione zero, sono le forme privilegiate attraverso le quali il narratore “gioca” con il sapere dello spettatore, rivelando o nascondendo informazioni a seconda delle necessità diegetiche . La suspense, nel suo “tipo” più puro, come già abbiamo accennato, è provocata dallo scarto di informazione tra il narratore e lo spettatore da una parte e il personaggio dall’ altra . Ad esempio La strada del mistero inizia in una piccola pensione familiare: una ragazza ospite, Vivian Eldon (Sally Forrest), ha una conversazione al telefono ambigua ed agitata. Quella stessa notte Vivian verrà uccisa ed il suo corpo sarà ritrovato solo sei mesi dopo. L’ esordio mostra la ragazza segnare sulla tapezzeria di fianco all’ apparecchio telefonico il numero che ha chiamato. In seguito, durante le indagini, la mancanza di quel particolare farà cadere i sospetti su un innocente. Nel finale poi, il tenente Morales (Ricardo Montalban) passerà molte volte vicino alla scritta, senza mai notarla: lo spettatore conosce l’ esistenza di quella chiave risolutiva, e la diegesi porta al culmine la tensione ritardando il più possibile il momento in cui finalmente il poliziotto la scopre. Similmente in Nodo alla gola Brandon (John Dall) e Philip (Farley Granger) nascondono il cadavere di David nella cassapanca su cui serviranno la cena ai suoi genitori ed alla fidanzata. La tensione maggiore si raggiunge quando uno dei personaggi rischia di aprire il mobile e di scoprirvi dentro il cadavere, come il momento in cui la signora Wilson (Edith Evanson), rigovernando le masserizie della cena, arriva fino a socchiudere il coperchio del cassettone, prima di essere fermata da Brandon. Nodo alla gola si basa interamente su questo meccanismo di suspense: ciò che vediamo nell’ esordio condizionerà in modo determinante la nostra visione; solo allo spettatore è concesso conoscere cosa è realmente accaduto a David (Dick Hogan) e la cinica messa in scena di Brandon e Philip. Quando invece allo spettatore viene nascosta volutamente un’ informazione si ha sorpresa: la prima scena di Odio implacabile mostra una collutazione tra due uomini; uno di questi rimane a terra, presumibilmente morto. L’ altro esce dalla stanza, trascinando via con sè una terza persona. Ma tutta la scena si svolge confusamente nella penombra e non è possibile riconoscere l’ assassino. I sospetti ricadranno poi logicamente sul giovane caporale Mitchell, misteriosamente scomparso. Le indagini sveleranno poi che il vero assassino è Montgomery (Robert Ryan) ed il movente l’ antisemitismo. La stessa costruzione a sorpresa si ritrova anche in Il caso Paradine : una bella e ricca signora, Maddalena Paradine (Alida Valli) una sera viene arrestata con l’ accusa di aver ucciso il marito. L’ opinione pubblica la crede innocente: la spiegazione la fornisce la signora Kean (Ann Todd), moglie dell’ avvocato che la difende in tribunale (Gregory Peck): “Una donna così bella non può essere colpevole”. Il mistero che l’ avvolge viene scambiato per fascino: lei stessa racconta di malavoglia la sua versione dei fatti, tralasciando sempre quell’ unica informazione fondamentale per risolvere il caso. Quando poi sarà costretta a parlarne si scoprirà colpevole. Suspense e sorpresa sono comunque termini complementari, non contradditori : possono infatti funzionare insieme nella narrazione in modi complessi e articolati, fondersi l’ una con l’ altra o trasformarsi reciprocamente sia a livello locale che investendo l’ intero narrato . L’ esordio dunque fonda e decide le informazioni da passare allo spettatore e quelle da tralasciare, secondo l’ effetto che la diegesi vuole provocare (suspense o sorpresa). Un fatto, un avvenimento, un colloquio cambiano il loro significato (per lo spettatore) se vengono proposti in un ordine o in un modo, anziché in un altro. La parte iniziale del film determina e fonda quest’ ordine, ponendosi quindi come il luogo in cui si organizza, attraverso la focalizzazione, il rapporto tra lo spettatore, il narratore ed i personaggi.
6. La voce acusmatica.
Michel Chion definisce acusmatica la voce che nasconde la sua origine,“che si sente senza vedere la fonte da cui proviene” . Egli tenta di dimostrare l’ importanza della voce in sè stessa, della voce come suono prima ancora che come parola, come mezzo attraverso il quale si esprime un linguaggio. “Certe analisi ‘semiologiche’ di film fanno largo uso di informazioni e di significanti che, in un dato film, hanno ricevuto esclusivamente da una voce: la voce di un personaggio oppure di un commento fuori campo. Ebbene, questa voce viene attraversata e subito dimenticata per andare dritti alla parola. Si direbbe che queste discipline non attribuiscano particolare importanza al fatto che a fornire loro un certo termine sia proprio la voce, piuttosto che un sottotitolo, una didascalia o persino il testo scritto della sceneggiatura” . L’ àcusma non si identifica con la voce del commentatore di immagini: la voce acusmatica deve almeno “far capolino nell’ immagine, nel territorio vero e proprio del film” . Elemento di squilibrio e tensione, l’ àcusma possiede dei veri e propri poteri: essere ovunque, vedere tutto, potere tutto, sapere tutto . L’ àcusma deve evitare di essere riconosciuta come corpo, di essere designata come soggetto “afferrabile”: perciò “non deve proiettarsi nello spazio” , non si deve definire. “Da una voce soggetto ci attendiamo un neutralità di timbro e d’ accento (…). Perché ogni spettatore possa farla veramente sua, questa voce deve avvicinarsi a ciò che sarebbe un testo scritto che parla nell’ intimità della lettura” . Voce acusmatica è quella che intercetta casualmente Leona (Barbara Stanwick) al telefono in Il terrore corre sul filo : la voce di due uomini che devono compiere un omicidio. Gradualmente si accorge di essere lei l’ oggetto della minaccia, una minaccia sconosciuta che diventa sempre più incombente. Le numerose panoramiche descrittive sugli oggetti della sua camera rendono efficacemente la paura del non visto. Leona è impotente fin dall’ inizio: bloccata a letto da una malattia cardiaca di origine psicologica e sola nella grande casa di New York, non può far altro che aggrapparsi all’ unico mezzo di comunicazione con l’ esterno, cercando di rintracciare il marito. I due elementi tematici che l’ esordio presenta come distinti, il ritardo inspiegabile di Henry e la telefonata dei due assassini che Leona intercetta, si riveleranno essere strettamente collegati alla fine del film. La telefonata intercettata è ciò che muove l’ azione: la voce acusmatica è un elemento di squilibrio, di tensione, che rende più urgente per Leona ritrovare il marito. Ma prima ancora il suo pensiero và alla donna che dovrà essere uccisa quella sera stessa, ignara e impotente di fronte al pericolo che sta correndo. Poi, man mano, viene a conoscenza di una storia a cui stenta a credere: è il suo sapere che provoca la suspense, la consapevolezza, raggiunta gradualmente, di essere lei l’ oggetto di quella telefonata, insieme alla speranza di star vivendo un incubo. Alla fine un uomo entra in casa: Leona lo sente salir le scale lentamente. La voce dell’ inizio diventa un pericolo reale, incombente. Mantiene sempre la sua aura di mistero: l’ uomo dà le spalle alla camera e, soprattutto, non parla: “fintanto che il volto e la bocca non ci vengono completamente mostrati e l’ occhio dello spettatore non è ancora in grado di verificare la coincidenza della voce con i movimenti della bocca (…), la deacusmatizzazione risulta incompleta e la voce conserva inalterata la sua aura di invulnerabilità” . Inoltre il corpo che non parla si pone in una posizione simmetrica alla voce che non si vede ; il limite ultimo dell’ àcusma e la bocca da cui esce la voce : l’ assassino rispondendo ad Henry al telefono dice “Mi spiace, ha sbagliato numero”, ma lo spettatore non lo vede in volto mentre proferisce queste parole. L’ àcusma dell’ esordio mantiene intatto il suo ‘potere assoluto’ fino alla fine. Dopo i titoli di testa appare, sovrimpressa all’ immagine di un centralino telefonico, la frase: “In the tangled networks of a great city, the telephone is the unseen link beetween a million lives…It is the servant of our common needs – the confidante of our inmost secret….life and happiness wait upon its ring…and horror…and loneliness….and DEATH!” Fin dall’ inizio quindi il ruolo tematico del telefono viene presentato sotto i due aspetti caratterizzanti nel film: il pericolo e la salvezza. Come nota Telotte un tale esordio è atipico per il genere noir, ma, in questo caso, efficace, perché collega l’ idea della fragilità delle relazioni umane con l’ atmosfera di ansia che caratterizza sempre la parola nel noir . Tanto più in quanto il telefono è uno strumento acusmatico: la parola duplica così la sua ambiguità, aggiungendo al sospetto della sua veridicità l’ indeterminatezza della sua provenienza. Il terrore corre sul filo è tratto da un famoso radiodramma dell’ epoca, e “la radio è per sua natura acusmatica” ; la trasposizione cinematografica ha non solo mantenuto intatta questa caratteristica, ma l’ ha addirittura esasperata: “al cinema ciò che abbiamo visto e sentito ci fa immaginare anche ciò che non abbiamo visto: senza escludere la possibilità, lasciata sempre aperta, di esserci ingannati” . Acusmatica, in questo senso, è anche la presenza dell’ assassino psicopatico di La città nera , che uccide, per vendetta, ad uno ad uno i componenti di una banda di malviventi, senza farsi mai vedere. La sua presenza-assenza diventa incombente e terrificante, una sorta di destino oscuro che procede inarrestabile per la sua strada . I film nei quali il telefono trasmette una voce acusmatica e ingannevole che innesca l’ intrigo sono molti in questi anni: in Morirai a mezzanotte è una telefonata che inganna Steve (Raymond Burr), il protagonista, rendendolo complice, suo malgrado, di una rapina; La strada del mistero (John Sturges, 1950) lega l’ enigma della morte di una giovane prostituta al numero di telefono che questa ha segnato sulla tapezzeria la sera stessa in cui è stata uccisa. Il telefono viene così spesso usato nell’ esordio proprio in quanto elemento acusmatico, e quindi ingannevole, ambiguo. La voce acusmatica è spesso anche una voce soggetto, la voce che racconta: perché lo spettatore la identifichi come tale, come il perno diegetico su cui si costruisce l’ azione, questa voce deve essere iglobante e incombente rispetto all’ immagine . E’ ciò che accade nell’ apertura di Dietro la porta chiusa , in cui è proprio la particolarità della voce che conferisce il senso alle immagini astratte che scorrono sullo schermo. Inoltre chi parla è Cecilia (Joan Bennet), una voce femminile: gli àcusma sono in genere quasi tutti maschili nel cinema classico e questa particolarità aumenta l’ attenzione dello spettatore. Poco dopo vedremo Cecilia che entra in chiesa per sposarsi, ma continua a parlare di se stessa al passato, quindi le immagini che vediamo appertengono al ricordo. Non conosciamo il luogo da cui parla: la sua voce, pacata e tranquilla, accenna a fatti misteriosi, terribili; và incontro al pericolo consapevolmente. In questo caso il punto di vista è interamente determinato dal suono della voce di Cecilia, la suspense è provocata da questo sottile meccanismo, basato sullo scarto tra il significato delle parole e il tono della sua voce, sulla rottura tra forma e contenuto . Anche Il bacio della morte inizia con una voce narrante femminile che presenta e introduce la storia. Ma solo alla fine questa àcusma si rivela come la voce della giovane moglie di Nick Bianco (Coleen Gray). E’ quindi retrospettivamente che vengono svelati i meccanismi di focalizzazione: ciò che sembrava una semplice voce di una commentatrice si scopre un personaggio ben definito, con un ruolo, seppure secondario, nella storia. L’ àcusma si rivela tale solo alla fine. Questo scarto ha la funzione di rendere fin dall’ inizio il racconto credibilmente obbiettivo: una didascalia subito dopo i titoli di testa dichiara la realtà della storia, girata nei luoghi stessi in cui è accaduta. La voce narrante off testimonia la condizione di Nick (Victor Mature), costretto ad una rapina perché senza lavoro, mosso dal desiderio di assicurare il regalo di natale alle sue due figlie. L’ obbiettività del racconto sarebbe stata messa in discussione se la voce narrante si fosse subito rivelata come la moglie del protagonista.